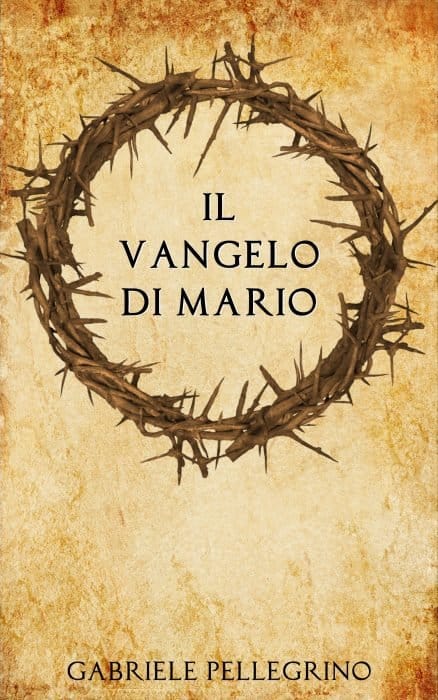Il volgare latino, ovvero la lingua parlata dal popolo(=volgus) romano, iniziò a cambiare lentamente quando cadde l’impero romano e le comunicazioni divennero difficoltose. I nuovi conquistatori in qualche caso adottarono i costumi locali (es. Italia, Spagna) e qualche volta no (es. Inghilterra), ma comunque influenzarono ovunque il linguaggio. In buona parte non fu una vera e propria scelta, ma dipese dal radicamento della cultura romana1. Dopotutto gli invasori erano una minoranza, probabilmente in percentuale inferiore agli immigrati oggi presenti nelle varie nazioni d’Europa. Anche se formavano la classe dirigente, la loro influenza aveva dei limiti.
All’inizio del secondo millennio il passaggio alle lingue romanze era completo e il volgare latino parlato in Italia era divenuto una serie di lingue locali.
A questo punto, il linguaggio letterario e scientifico era ancora il latino classico, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Nel XIV secolo Dante Alighieri scrisse La [Divina]2Commedia, la prima grande opera scritta in quello che sarebbe diventato italiano. Anche Boccaccio e Petrarca furono grandi poeti che influenzarono la letteratura europea. L’importanza di questi poeti non è dovuta solo al fatto che scrissero capolavori, ma anche poiché furono i primi a sostenere l’uguaglianza delle lingue volgari e del latino. In questo cambiamento culturale, l’uguaglianza con i grandi antichi, giace il fondamento del Rinascimento.
I popoli italici avevano una grande rilevanza nei commerci e questo fece sì che il veneziano e il genovese guadagnassero una vasta diffusione, diventando la base per l’originale lingua franca, idioma usato per i commerci mediterranei. Il nome infatti, non deriva dal fatto che fosse legato al francese, ma perché tutti gli europei erano chiamati franchi dai bizantini3, a loro volta chiamati greci. Appellativi nati soprattutto per questioni politiche circa i due imperi: Sacro Romano Impero e Impero Romano d’Oriente, spregiativamente chiamati dalle parti avverse Impero dei Franchi e Impero dei Greci. Per dire, appunto, che gli altri non erano veri romani.
Anche il siciliano ebbe una certa breve rilevanza letteraria dopo la conquista Normanna. Ma nonostante i degni avversari, fu proprio l’eredità letteraria del fiorentino, unito all’importanza economica di Firenze, che fu fondamentale per l’adozione di un linguaggio comune durante il Rinascimento. Questo linguaggio comune era principalmente usato alle corti dei diversi stati della penisola italiana.
Ormai divenuto senza rivali, rimaneva comunque poco utilizzato al di fuori della buona società, fatto ovviamente eccezione per i toscani. Pertanto un’altra opera fondamentale per la definizione del linguaggio fu I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, nel XIX secolo. Originariamente Fermo e Lucia,
prima che Manzoni andasse a «risciacquare i panni nell’Arno», cioè rivedesse il romanzo per depurarlo di molte influenze lombarde e avvicinarlo maggiormente alla lingua fiorentina.
Benché l’opera di standardizzazione potesse definirsi completa dal punto di vista letterario, la sua diffusione come lingua parlata rimaneva limitata. Semplicemente non c’era un motivo o un modo per diffondere una lingua standard tra il popolo. Al momento della riunificazione dell’Italia, nell’anno 1861, soltanto una piccola minoranza della popolazione, circa il 5% parlava l’italiano. Anche se bisogna contestualizzare questa informazione con due aggiunte:
- le stime esatte sono difficili, ma perlomeno il 20-30% la maggior parte degli italiani riusciva a capirlo, a comunicare in maniera limitata con funzionari e forestieri che incontravano
- in tutti i Paesi moderni comunque non si parlava una lingua standard, per il semplice fatto che non esistevano mezzi di comunicazione di massa che potessero creare questo standard. Per esempio, in Francia e Inghilterra sostanzialmente il numero di parlanti poteva essere il doppio, e lo stesso valeva per le persone in grado di capire la lingua nazionale, quindi il 40-60%
A parte la progressiva educazione della popolazione, l’evento che ne segnò la definitiva affermazione popolare fu la Prima Guerra Mondiale. La leva portò insieme milioni di persone e li costrinse, ufficiali e soldati, nella guerra e nella vita sociale, a parlare una lingua comune per sopravvivere. Una comprensione sporadica o imprecisa non era più sufficiente: per capire ordine e coordinare movimenti era necessaria una lingua condivisa.
Note
1. anzi i Longobardi, conquistatori d’Italia, furono alquanto sprezzanti dei locali e delle loro tradizioni, ma non riuscirono a cambiarle [↵]
2. l’aggettivo fu aggiunto da Boccaccio [↵]
3. peraltro il nome bizantino è un’invenzione moderna, loro si chiamavano romani, anche se in greco [↵]